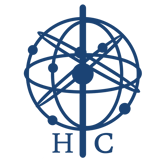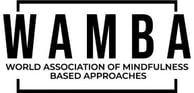Mindfulness e Cura di Sé nell'azione Umanitaria.
Questo post è stato originariamente pubblicato come Protecting the Humanitarian Individual: Mindfulness and Self-Care in Humanitarian Action sul blog The Individualisation of War, un progetto dell'Istituto universitario europeo.
Mindfulness e Cura di Sé nell'azione Umanitaria.


Questo post è stato originariamente pubblicato come Protecting the Humanitarian Individual: Mindfulness and Self-Care in Humanitarian Action sul blog The Individualisation of War, un progetto dell'Istituto universitario europeo
***
Sono arrivato a Nablus nel 2008, in mezzo alla devastazione umana ed emotiva che ha seguito la Seconda Intifada. Come psicologo con una ONG internazionale, sono venuto in Cisgiordania per fornire supporto terapeutico ai palestinesi che portavano le ferite del conflitto in corso e dell'occupazione militare: ho lavorato con ex prigionieri, madri che avevano perso i loro figli in operazioni armate, famiglie le cui i mezzi di sussistenza erano costantemente minacciati dall'espansione degli insediamenti israeliani.
Come la maggior parte dei nuovi arrivati sul campo, la mia idea di lavoro umanitario è stata influenzata dall'immagine trasmessa dai media: uomini e donne che volano verso località remote per aiutare i sopravvissuti a catastrofi naturali e guerre tragiche. Inutile dire che i palestinesi mi hanno subito insegnato la lezione che dovevo imparare: nella migliore delle ipotesi i professionisti umanitari sono "altruisti egoisti" il cui desiderio di aiutare "sconosciuti lontani" è un modo per soddisfare il nostro bisogno di significato e scopo. C'è ancora una sorta di retorica mitica intorno al lavoro umanitario che ci impedisce di riconoscere "che è probabile che le nostre motivazioni personali combinino anche fattori morali psicologicamente sani con alcune motivazioni abbastanza disfunzionali" (Slim, 2015: p. 233). Questo spesso va di pari passo con l'incapacità di vedere l'umanità e la vulnerabilità che accompagna coloro che intraprendono un lavoro umanitario. Se il principio dell'umanità riguarda l'affrontare la sofferenza ovunque si trovi, e lo scopo dell'azione umanitaria è proteggere la vita e garantire il rispetto per gli esseri umani, allora le agenzie umanitarie hanno il dovere morale di applicare questo stesso principio anche all'individuo umanitario.
Questa riflessione mi ha accompagnato nel prendere coscienza di come, nel tentativo di prendersi cura degli altri, la prima vittima potesse essere la mia stessa salute mentale. Ho imparato presto che il più grande stress per tutti noi della squadra non erano i posti di blocco militari, ma le relazioni tese con i manager, i conflitti di squadra o quelle che a posteriori sembrano meschine discussioni sul lavaggio dei piatti o sul coprifuoco. Le minacce al nostro benessere provenivano dall'interno, non solo dall'ambiente politico instabile. Ciò significava che ero molto più a rischio di esaurimento, o esaurimento fisico, mentale ed emotivo a causa di una combinazione del mio "complesso del salvatore" e disfunzioni organizzative, che del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) causato dal vivere e lavorare in una zona di conflitto. Ho iniziato a rivolgere sempre di più lo specchio psicologico a me stesso e alla mia stessa gente, professionisti umanitari. La mia domanda iniziale era: come potremmo essere meglio attrezzati per lavorare con persone che soffrono a causa della violenza politica? È qui che la Mindfulness ha iniziato a svolgere un ruolo nel mio lavoro umanitario, portandomi a una serie di domande e dilemmi che continuo a ricercare oggi diversi anni dopo aver lavorato a Nablus.
Che tipo di individui scelgono una carriera umanitaria? Quali fattori motivanti fanno decidere su una professione così potenzialmente pericolosa? Quali sono le principali cause di stress e sofferenza per gli operatori umanitari? Come rispondono psicologicamente? In che modo le agenzie umanitarie supportano il loro personale? E, soprattutto, in che modo la salute mentale ed emotiva degli operatori umanitari influisce sul loro lavoro sul campo? Il mio interesse primario risiede nell'intersezione tra la salute mentale degli individui, la cultura organizzativa e l'azione umanitaria: il nostro benessere e la cultura che respiriamo nelle nostre agenzie possono essere un catalizzatore per un'azione efficace e umana? E quando diventano un ostacolo?
Nel tentativo di far luce su queste domande ho deciso di condividere con gli operatori umanitari la pratica della cura di sé che avevo trovato utile come psicologa sul campo.


Nel 2011 ho deciso di insegnare la mindfulness per la riduzione dello stress e la prevenzione del burnout agli umanitari in Palestina. La mindfulness è una pratica basata sull'antica meditazione buddista e anche nella sua forma secolare occidentale può essere benefica a diversi livelli: 1) come approccio alla cura di sé, e 2) come pratica etica riflessiva.
Come approccio alla cura di sé, la Mindfulness implica che ci sediamo intenzionalmente in silenzio, respiriamo e siamo consapevoli delle sensazioni del corpo, delle emozioni, dei pensieri che corrono attraverso la mente. Fare spazio alla quiete e al silenzio è essenziale per gli operatori umanitari impegnati in attività frenetiche e impegnative che possono logorarli fisicamente, emotivamente e mentalmente. Fare il punto e portare l'attenzione su ciò che accade dentro di noi può aiutarci a rilassarci e prevenire la spirale della sofferenza.
Come pratica etica riflessiva, la mindfulness può essere definita come la capacità di prendere decisioni sagge di fronte a incertezze e/o avversità, mantenendo un atteggiamento compassionevole verso se stessi e gli altri. Una tale pratica può aiutare gli umanitari ad essere più consapevoli di tutta una serie di questioni che si trovano all'ombra del lavoro di aiuto come le dinamiche di potere o comportamenti inappropriati che contribuiscono all'immagine decadente che gli umanitari hanno nel campo. In questo modo può aprire uno spazio per riflettere sulle implicazioni etiche delle nostre azioni. Come un uccello, la consapevolezza/Mindfulness ha due ali: la compassione, che include la cura di sé, e la saggezza, che comprende la riflessione sul sé e la sua interazione con il mondo. Entrambe le qualità della consapevolezza sono importanti per l'individuo umanitario: la cura di sé senza riflessione può renderci autoindulgenti, la riflessione senza cura di sé può renderci cinici, ipocriti e freddi. Oggi vediamo gran parte della pratica tradizionale della Mindfulness spogliata della sua dimensione etica e trasformata in un bene per la cura di sé insieme allo yoga, alla massoterapia o a un trattamento termale. Ma l'etica è una componente essenziale della consapevolezza/Mindfulness, così come del lavoro umanitario.
Come scrive Hugo Slim nel suo nuovo libro Humanitarian Ethics (2015, p. 231): “Il modo in cui ogni persona in ogni agenzia decide di essere umanitaria quando si alza la mattina determina il tono dell'etica umanitaria in tutto il mondo.


Se la maggior parte di noi sceglie di essere di principio, pratica, audace, coraggiosa e riflessiva e continua a lottare per rimanere vicino alle comunità colpite e creare soluzioni con loro, allora l'azione umanitaria ha buone possibilità di essere rilevante, efficace e rispettata. Se troppi di noi diventano cinici, cauti, burocratici, egoisti, inefficienti e preferiscono stare seduti con i nostri laptop piuttosto che con le persone che soffrono intorno a noi, allora le nostre agenzie e il sistema umanitario rifletteranno questi atteggiamenti e attireranno risentimento piuttosto che ammirazione. " Nella mindfulness così come nella pratica umanitaria coltiviamo l'etica, non come una speculazione astratta, ma nell'esperienza quotidiana vissuta, con i suoi fastidiosi problemi, le relazioni tese con il quartier generale e le difficoltà con manager e colleghi. L'idea di alleviare la sofferenza degli altri senza coltivare umanità e rispetto verso se stessi e verso i propri coetanei più immediati – cioè all'interno delle nostre stesse organizzazioni – è un'impresa viziata.
Le agenzie umanitarie portano ancora una "cultura maschilista" in cui la salute psicologica del personale sul campo viene generalmente ignorata, a meno che non si verifichi qualche incidente critico. Ma essere un umanitario e non essere toccati dalla sofferenza testimoniata, è pericoloso quanto piangere alla vista di ogni persona in difficoltà, perché stordendoci perdiamo la nostra empatia e umanità. In un settore in cui l'instabilità lavorativa è alta e la salute mentale è ancora stigmatizzata, è noto che gli operatori umanitari nascondono le proprie sofferenze per paura di non essere considerati idonei per il lavoro. E se le agenzie umanitarie coltivassero dall'interno la stessa umanità che pretendono di avere per "stranieri lontani"? Nel loro sforzo di alleviare la sofferenza degli altri, alcune agenzie potrebbero aver dimenticato che il benessere del loro bene più prezioso, ovvero il proprio personale, è importante. Se le agenzie umanitarie vogliono adempiere al loro dovere di diligenza per prevenire e affrontare potenziali eventi traumatici, non solo devono essere consapevoli delle minacce esterne come i rapimenti e altre forme di violenza contro gli operatori umanitari.
Hanno anche bisogno di cercare dentro di sé le "vulnerabilità interne" (Fast, 2014), favorire il supporto tra pari, coltivare le soft-skill e instillare empatia, rispetto e cura all'interno della propria cultura. La Mindfulness non è una panacea e temo che il suo valore più profondo, che è la sua posizione etica di saggezza e compassione, sia stato ostacolato da un supermercato di guru dell'auto-aiuto. Tuttavia, se rimaniamo fedeli allo spirito di meditazione, con la sua combinazione di cura di sé etica e riflessione, rimane un approccio valido e stimolante che può aiutare i professionisti a coltivare l'umanità e sviluppare il coraggio morale, ricordando che la cura e il rispetto per altri iniziano da dentro di noi e all'interno delle nostre organizzazioni.
***
Riferimenti:
Fast, L. (2014) Aid in Danger: The Perils and Promise of Humanitarianism, University of Pennsylvania Press: Philadelphia. Slim, H. (2015) Etica umanitaria: una guida alla moralità degli aiuti in caso di guerra e disastri, Hurst Publishers: London.
Articolo originale
Mindfulness and Self-Care in Humanitarian Action
This post was originally published as Protecting the Humanitarian Individual: Mindfulness and Self-Care in Humanitarian Action on The Individualisation of War blog, a project by the European University Institute
***
I arrived in Nablus in 2008, amid the human and emotional devastation that followed the Second Intifada. As a psychologist with an international NGO, I came to the West Bank to provide therapeutic support to Palestinians who carried the wounds of the ongoing conflict and military occupation: I worked with former prisoners, mothers who had lost their sons in armed operations, families whose livelihood was constantly threatened by expansion of Israeli settlements.
Like most newcomers to the field my idea of humanitarian work had been influenced by the image conveyed by the media: men and women flying off to remote locations to help survivors of natural catastrophes and tragic wars. Needless to say the Palestinians quickly taught me the lesson I needed to learn: at best humanitarian professionals are “selfish altruists” whose desire to help “distant strangers” is a way to fulfil our own need for meaning and purpose. There is still a sort of mythical rhetoric around humanitarian work that prevents us from recognising “that our personal motives are likely to combine psychologically healthy moral drivers with some fairly dysfunctional motivations too” (Slim, 2015: p. 233). This often goes hand-in-hand with an incapacity to see the humanity and vulnerability that accompanies those who take up humanitarian work. If the principle of humanity is about addressing suffering wherever it is found, and the purpose of humanitarian action is to protect life and ensure respect for human beings, then humanitarian agencies have the moral duty to apply this very principle to the humanitarian individual as well.
This reflection accompanied me as I became aware of how in an attempt to care for others, the first casualty could be my very own mental health. I soon learned that the biggest stressor for all of us in the team were not military checkpoints, but strained relations with managers, team conflicts or what in hindsight seem petty discussions over washing up or curfew. Threats to our well-being came from within, not just from the volatile political environment. This meant that I was much more at risk of burnout, or physical, mental and emotional exhaustion due to a combination of my own “saviour complex” and organisational dysfunctions, than of post-traumatic stress disorder (PTSD) caused by living and working in a conflict-zone. More and more I started to turn the psychological mirror towards myself and my own people, humanitarian professionals. My initial question was: how could we be best equipped to work with people who are suffering due to political violence? This is where mindfulness began to play a role in my humanitarian work leading me to a sequel of questions and dilemmas that I continue to research today several years after working in Nablus. What kind of individuals choose a humanitarian career? What motivating factors make one decide on such a potentially dangerous profession? What are the main causes of stress and suffering for aid workers? How do they respond psychologically? How do humanitarian agencies support their staff? And most importantly how does the mental and emotional health of aid workers affect their work in the field? My primary interest lays at the intersection between individuals’ mental health, organisational culture and humanitarian action: can our own well-being and the culture that we breathe in our agencies be a catalyst for effective and humane action? And when do they become an obstacle?
In an attempt to shed light on these questions I decided to share with aid workers the self-care practice that I had found helpful as a field psychologist. In 2011 I set out to teach mindfulness for stress reduction and burnout prevention to humanitarians in Palestine. Mindfulness is a practice based on ancient Buddhist meditation and even in its secular western form it can be beneficial at different levels: 1) as a self-care approach, an 2) as an ethical reflective practice.
As a self-care approach mindfulness entails that we intentionally sit quietly, breathe and be aware of body sensations, emotions, thoughts racing through the mind. Making space for stillness and silence is essential for aid workers who are engaged in frantic and demanding activities that can wear them down physically, emotionally and mentally. Taking stock and bringing attention to what goes on within us can help us relax and prevent the spiralling of suffering.
As an ethical reflective practice, mindfulness can be defined as the capacity to make wise decisions in the face of uncertainties and/or adversities, while maintaining a compassionate attitude towards oneself and others. A such the practice can help humanitarians to be more aware of a whole range of issues that sit in the shadow of aid work such as power dynamics, or inappropriate behaviours that contribute to the decaying image that humanitarians have in the field. In this way it can open a space to reflect on the ethical implications of our actions. Like a bird, mindfulness has two wings: compassion, which includes self-care, and wisdom which encompasses reflection on the self and its interaction with the world. Both qualities of mindfulness are important for the humanitarian individual: self-care without reflection can make us self-indulgent, reflection without self-care can make us cynical, self-righteous and cold.Today we see much of the mainstream practice of mindfulness stripped of its ethical dimension and turned into a self-care commodity alongside yoga, massage therapy or a spa treatment. But ethics is an essential component of mindfulness, as it is of humanitarian work. As Hugo Slim writes in his new book Humanitarian Ethics (2015, p. 231): “The way each person in every agency decides to be humanitarian when he or she gets up in the morning sets the tone of humanitarian ethics around the world. If most of us choose to be principled, practical, daring, courageous and thoughtful, and keep struggling to stay close to affected communities and create solutions with them, then humanitarian action stands a good chance of being relevant, effective and respected. If too many of us become cynical, cautious, bureaucratic, self-interested, inefficient and prefer to sit with our laptops rather than with people suffering around us, then our agencies and the humanitarian system will reflect these attitudes and attract resentment rather than admiration.” In mindfulness as well as in humanitarian practice we cultivate ethics, not as some abstract speculation, but in the lived everyday experience, with its nagging problems, strained relationships with HQ, and difficulties with managers and colleagues. The idea of alleviating the suffering of others without cultivating humanity and respect towards oneself, and towards one’s most immediate peers – that is within our own organisations – is a flawed enterprise.
Aid agencies still carry a “macho culture” where the psychological health of field staff is generally ignored, unless some critical incident occurs. But being a humanitarian and not being touched by the suffering witnessed, is as dangerous as crying at the sight of every person in distress, because by numbing out we lose our empathy and humanity. In a sector where job instability runs high, and mental health is still stigmatised, aid workers are known to hide their own suffering for fear of not being seen fit for the job. What if humanitarian agencies cultivated from within the very humanity that they purport to have for “distant strangers”? In their strive to alleviate the suffering of others, some agencies may have forgotten that the well-being of their most valuable asset, that is their own staff, matters. If humanitarian agencies want to fulfil their duty of care to prevent and address potential traumatic events, not only do they have to be mindful of external threats such as abductions, and other forms of violence against aid workers. They also need to look within for “internal vulnerabilities” (Fast, 2014), foster peer support, cultivate soft-skills, and instil empathy, respect and care within their own culture. Mindfulness is no panacea and I am afraid that its deeper value, which is its ethical stance of wisdom and compassion, has been hampered by a supermarket of self-help gurus. Yet, if we remain true to the spirit of meditation, with its combination of ethical self-care and reflection, it remains a valid and inspiring approach that can help aid professionals to cultivate humanity and develop moral courage, while remembering that care and respect for others start from within ourselves and within our organisations.
***
References:
Fast, L. (2014) Aid in Danger: The Perils and Promise of Humanitarianism, University of Pennsylvania Press: Philadelphia. Slim, H. (2015) Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster, Hurst Publishers: London.